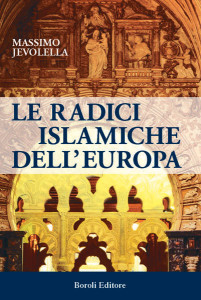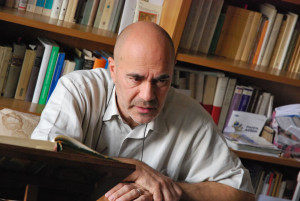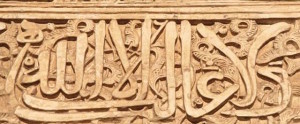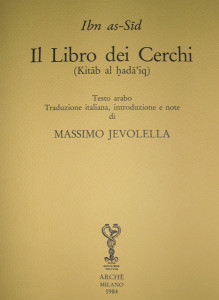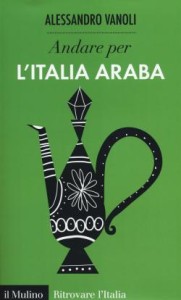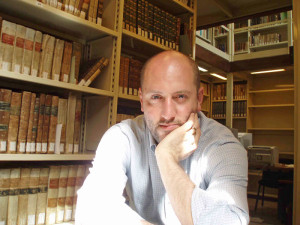Gli Angeli della Bibbia che appaiono ai profeti giudei e gli extraterrestri che appaiono ai cosiddetti “contattisti” e affidano loro messaggi di pace per l’umanità, sono una sola ed unica cosa? Sono la manifestazione dello stesso fenomeno, percepito e raccontato in maniera diversa, in base alle specificità storiche delle culture di appartenenza?
Si tratta di una “vexata quaestio” della quale si discute almeno dai tempi di George Adamski e che, se nei Paesi anglosassoni ha assunto una linea estranea se non ostile alla religione cristiana (Eric Von Däniken, Raymond Drake), in Italia ha dato luogo a un interessante tentativo di conciliazione fra “religione dei dischi volanti” e cristianesimo, soprattutto dopo la pubblicazione del libro di Giorgio Dibitonto «Angeli in astronave». In effetti, la natura degli incontri con le creature aliene e soprattutto il tono dei loro messaggi non è incompatibile con l’insegnamento cristiano: vi si parla di amore e fratellanza universale, di ritorno del nostro pianeta a Dio e di una prossima venuta di Cristo “sulle nubi”, il che, nel loro linguaggio, sembra voler dire “sulle astronavi”.
A sottolineare la compatibilità dell’ufologia, così intesa, e il cristianesimo, ci ha pensato il noto demonologo padre Corrado Balducci, autore di alcuni studi fondamentali sul fenomeno della possessione diabolica. Balducci, che è scomparso nel 2008, aveva partecipato alla presentazione del libro di Dibitonto, il 25 marzo 1983, presso la Libreria Internazionale “Remo Croce” - insieme al giornalista della R.A.I. Augusto Giordano e all’ufologo Eufemio Del Buono -, mentre ricopriva l’incarico di Direttore dell’Ufficio Evangelizzazione e Cultura del vaticano. La sua, dunque, era una voce autorevole che, se da un lato esprimeva le opinioni personali del sacerdote, dall’altro suggeriva una posizione possibilista della Chiesa cattolica circa il messaggio diffuso a nome degli extraterrestri da Dibitonto.
Riportiamo alcuni passaggi particolarmente significativi del discorso tenuto da Balducci in quella occasione (e riportato nel sito Internet «Angeli in astronave» di Giorgio Dibitonto), per svolgere in seguito alcune riflessioni; non senza osservare, in via preliminare, che Giordano Bruno era incorso nei fulmini dell’Inquisizione anche per aver sostenuto la pluralità dei mondi abitati (tesi che però non aveva fatto scandalo nel 1440, quando ad esporla era stato il cardinale e teologo Nicolò Cusano nella sua opera «De docta ignorantia»):
«Non nascondo che ho iniziato la lettura di questo libro con un certo scetticismo e con un animo da inquisitore cercando che cosa ci fosse che potesse portare contro certe verità fondamentali.
L’Ufologia è indubbiamente una materia molto suggestiva e in essa pertanto alcuni disturbi fisiologici e soprattutto psichici quali l’illusione, l’allucinazione, la suggestionabilità, possono giocare un ruolo importante: Ma che tutto si riduca a questo è una cosa insostenibile e pericolosa a motivo delle ormai troppe e troppo varie testimonianze. Quindi non è tutta fantasia. Siamo giunti ad un momento storico nel quale bisogna dire: qualche cosa di vero c’è!”.
Io, anni fa, scrissi qualche cosa nei riguardi di un altro campo scientifico o quasi, lo spiritismo. E ho scritto nel 1959: “Una incredulità esagerata, oltre ad essere contraria al più elementare senso di prudenza, può avere nel campo religioso ripercussioni funeste”. E qui citavo alcune frasi del libro “Spiritismo e Chiesa”: “Da un punto di vista logico, i cristiani che accettano i miracoli ed altri incidenti raccontati dal Vangelo, si trovano in una situazione eccezionale. Non possono coerentemente respingere con ostinazione le reiterate testimonianze di moderni testimoni attendibili che riferiscono ciò che i loro occhi hanno veduto e ciò che le loro orecchie hanno udito in circostanze che apparentemente escludono la possibilità di inganno. […]
Non è più il caso di dubitare. Oramai una porta è aperta agli ufologi, i fenomeni esistono, ne esisteranno dieci anziché cento, ma i fenomeni esistono. Ma come si spiegano questi fenomeni?
Le due attribuzioni possibili sono o eventuali abitanti di altri mondi o Angeli e Anime dei Defunti. Con gli Angeli mettiamo pure la Madonna, mettiamo pure, se si vuole, anche Gesù. Per quanto concerne i cosiddetti marziani, circa la possibilità della abitabilità di altri pianeti, noi non sappiamo nulla di certo e questo spiega anche perché il nostro Eufemio Del Buono espone nel suo fervore le motivazioni per l’atteggiamento attendistico della Chiesa in subordine alla scienza. Però la Chiesa può dire molto. La cosa è possibile. Parlo ovviamente dal punto di vista religioso e non dal punto di vista scientifico. Le possibilità di Dio sono infinite. […]
C’è stato un salesiano, morto alla fine del secolo scorso, Don Beltrami [precisamente, venerabile dal 1966], per il quale è in corso la causa di beatificazione. Questi, nelle sue preghiere, non mancava mai di ricordare i possibili abitanti di altri pianeti e scrisse un volumetto per dimostrare la possibilità di abitabilità di altri pianeti. Un fatto è, come dice San Paolo, che Cristo è centro e capo della creazione dell’universo. Non esistono pertanto mondi che non abbiano un riferimento a Cristo. Dai testi biblici si può affermare che Cristo, come Verbo Incarnato, esercita il suo influsso su tutti i possibili pianeti abitati. […] Il Credo di Epifanio, il Concilio di Costantinopoli, il Credo Costantinopolitano che recitiamo nella Messa in italiano: “Creatore di tutte le cose visibili e invisibili”. […] Nel racconto bellissimo della scena della morte, cioè questa liberazione dell’anima, si capisce che già in questa vita c’è un’esigenza dell’anima di spiritualizzare il corpo. Quindi che dopo la morte esistano questi corpi sempre più spiritualizzati, non urta minimamente con posizioni teologiche. […] Esiste quasi come un corpo mistico naturale, non so se sia mai stata detta una frase del genere, ma mi sentirei di sostenerla. Noi conosciamo il corpo mistico che è il corpo che unisce i viventi cristiani, ma c’è anche il corpo mistico naturale che unisce tutti, non solo i viventi e in questo caso neppure i battezzati, ma anche i non viventi, la natura insomma. Il bene e il male degli uni non si ripercuote solo sugli altri, come nel caso del corpo mistico teologicamente parlando, ma sul mondo, sulla natura. […]
Un altro argomento interessante è il loro aiuto [degli extraterrestri] ai buoni, in questo cataclisma ed anche questo l’ho trovato in alcune profezie. Poi a questo cataclisma succederà un èra di felicità sulla Terra. E a Giorgio questo è stato detto, gli è stato detto di questo millenarismo. Questo millenarismo è qui nel libro inteso come Nuovo Eden e posso dire che c’è una risposta del Santo Uffizio che dice che ciò è una dottrina che non si può insegnare con tranquillità perché non ci sono le prove, quindi vedete, in fondo la Chiesa è stata molto larga. Non dobbiamo illuderci però che non arrivi una guerra, perché se non ci fosse più una guerra, noi avremmo cambiato natura. L’uomo, finché è l’uomo, darà motivo alla guerra nella famiglia, nel partito, nell’associazione, nella scuola… ci si adatta ai tempi. Le ultime guerre sono mondiali e saranno sempre più mondiali perché il mondo diventa sempre più piccolo, grazie al progresso dei trasporti e delle telecomunicazioni. Non dobbiamo illuderci che queste chiamate piccole guerre come Palestina, Afganistan, Vietnam, impediscano altre guerre più grandi. Come non dobbiamo lo dobbiamo illuderci col fatto delle bombe atomiche. Chi è così semplicistico fra noi da pensare che se c’è una guerra la combattano con le armi della guerra precedente?
Mi ha fatto molto piacere leggere il libro di Giorgio, perché mi ha dato motivo di vedere come oramai non è più l’uomo che appella il castigo alla bontà che è infinita, è misericordiosa, che però ha un limite pure quella, come è scritto nel libro. Ma non è solo l’uomo, ma è il mondo che farà la guerra anche all’uomo. Alla luce di queste considerazioni, né per gli uni né per gli altri si può escludere la possibilità di quanto è esposto nel libro. Nulla nel libro esiste, che urti con qualche verità rivelata e questo rappresenta un buon argomento a favore della autenticità del fatto.
Se qualcuno, come Giorgio, per motivi che la Provvidenza conosce e che si risolvono al bene dell’umanità, ha avuto il privilegio di penetrare nei segreti dell’aldilà e assaporarne in qualche modo le meraviglie, noi siamo grati anzitutto a Dio e poi a Lui che, attraverso una descrizione molto semplice, toccante e sentita, ce ne ha resi partecipi. Il libro, oltre che rappresentare un viaggio bellissimo, in un mondo paradisiaco, è un poema dell’Amore di Dio per noi e un pressante, ripetuto invito all’Amore, a Dio, al prossimo e alla natura, è un serio monito ad abbandonare l’odio e il male e di particolare conforto per quanto concerne il terribile cataclisma e fonte di grande gioia per ciò che ci attenderà dopo la prova.»
In effetti, le esperienze riferite da Dibitonto ricordano più delle estasi di tipo mistico, che degli eventi fisici veri e propri, con un ”dentro” e dun “fuori” chiaramente riconoscibili, e con un certo grado di verosimiglianza oggettiva.
Sia chiaro: ogni fatto che ci vede coinvolti, e del quale diveniamo, più o meno volontariamente, protagonisti, è filtrato dalla nostra coscienza e non può mai essere riferito in termini puramente oggettivi: quest’ultima era la pretesa della scienza positivista, ma la scienza contemporanea, specialmente dopo le ultime scoperte nel campo della fisica delle particelle sub-atoniche, l’ha definitivamente relegata fra le aspirazioni impossibili. Tutto ciò che noi esperiamo, lo esperiamo attraverso i NOSTRI organi di senso e la NOSTRA coscienza, dopo di che tentiamo di descriverlo con le NOSTRE parole, espressione del NOSTRO universo concettuale e, naturalmente, del NOSTRO livello di consapevolezza.
Da ciò non deriva, tuttavia, che qualsiasi allucinazione, sogno o fantasticheria abbiano lo stesso valore oggettivo di un evento perfettamente “reale”; significa solo che i confini fra ciò che consideriamo “oggettivo” e ciò che non lo è, fra ciò che consideriamo “reale” e ciò che non lo è, sfumano più di quanto saremmo disposti ad ammettere per amore delle nostre confortanti certezze. Il valore veritativo di un evento intensamente vissuto è sempre lo stesso, anche se i riscontri oggettivi sono scarsi o nulli: in altre parole, per noi è vero ciò che è vero per la nostra coscienza, in quel dato momento e in quelle date circostanze.
Un esempio banale: per un uomo che si trovi, disarmato, faccia a faccia con un leone, a pochi passi di distanza dalla belva che lo fissa minacciosa, il valore del tempo non è certamente quello segnato dalle lancette dell’orologio: per lui, i secondi sono lunghi come delle ore, i minuti come dei secoli. Se dovesse riferire la sua esperienza, non parlerebbe certamente di una esperienza brevissima, anche se tale può essere stata “oggettivamente”, ma di una lunghezza interminabile, addirittura eterna; meglio ancora: di un esperienza FUORI DAL TEMPO, nella quale il tempo sembra sia stato sospeso, oltrepassato, annientato.
Un altro esempio: per un uomo che sta vivendo un incubo, magari dovuto all’assunzione di sostanze allucinogene, il ragno gigantesco che avanza verso di lui per ghermirlo nelle sue zampe pelose dalla lunghezza spropositata, è tanto reale quanto potrebbe esserlo, per lui sveglio, la tazzina del caffè posata sul tavolo o il giornale fresco di stampa, appena acquistato dall’edicolante. L’angoscia che quella visione gli ha provocato era assolutamente reale, in nulla distinguibile dall’angoscia che avrebbe provato per un pericolo “oggettivo”, come potrebbe esserlo accorgersi improvvisamente, durante una gita in macchina lungo una discesa a tornanti d’una strada di montagna, che i freni, chi sa come, sono sul punto di cedere.
Fatta questa precisazione, resta il fatto che noi abbiamo bisogno, per esigenze pratiche derivanti dal nostro senso di identità e anche dalle nostre relazioni sociali, di distinguere, almeno in linea di massima, ciò che accade “dentro” la nostra coscienza, da ciò che accade “fuori” o, per dir meglio, da ciò che accade ANCHE al di fuori di essa. Ebbene, le esperienze di Giorgio Dibitonto con gli alieni sembrano doversi collocare in una “zona grigia” che non rientra con sicurezza in nessuno dei due ambiti, ma che sfuma impercettibilmente dall’uno nell’altro.
Prendiamo il racconto del primo “incontro”, così come egli stesso lo descrive (da: G. Dibitonto, «Angeli in astronave», Roma, Edizioni Mediterranee, 1983, p. 27):
«Ero sul letto per un breve riposo pomeridiano. Stavo prendendo sonno, quando una nitida visione apparve dinanzi ai miei occhi. Vedevo un bosco, i suoi alberi, il sottobosco e l’erba divisa da un sentiero. Mi sentii invadere da una pace profonda.»
Come si vede, per sua stessa ammissione, il protagonista si stava appisolando, dunque la sua coscienza si trovava in quella terra di nessuno che si colloca fra la veglia e il sonno e che, lo sappiamo dai racconti di innumerevoli esperienze mistiche, si presta particolarmente all’apertura spontanea verso piano di consapevolezza esistenziale diversi da quello ordinario.
Difficile, perciò, se non impossibile, voler distinguere se il soggetto, in quel momento, fosse desto o addormentato; se quel bosco, che gli apparve così vividamente e che suscitò in lui un senso così riposante di pace e benessere, fosse una visione “reale” o no (a questa domanda risponderanno gli eventi successivi; qui ci limitiamo a evidenziare come il colore verde, tipico di un bosco nella bella stagione, è particolarmente rilassante per la psiche umana, come è stato mostrato “ad abundantiam” da tutta una serie di ricerche psicologiche.
Il racconto prosegue così:
«Attesi di comprendere il significato di quanto mi stava accadendo, e allora udii la voce di Raffaele che mi disse: “Osserva bene il luogo. Lo riconoscerai. È stato prescelto per un nostro incontro”.
Tutto scomparve, e mi restò una calma serena »
L’entità chiamata “Raffaele” era già apparsa due volte al protagonista, in casa sua, nello stesso luogo e con le identiche modalità. Mentre l’uomo si trovava in uno stato di sereno rilassamento, una figura gli si era materializzata davanti, splendente di luce, con una lunga tunica scintillante, un paio d’ali e i piedi nudi; la seconda volta gli aveva detto il proprio nome e lo aveva invitato a leggere il Libro di Tobia, nella Bibbia, “per conoscerlo meglio”. Evidentemente intendeva presentarsi come la guida verso la dimensione ulteriore; è significativo che la seconda apparizione fosse avvenuta nei giorni intorno alla Pasqua, il che ne sottolinea il carattere religioso.
Si noti l’andamento dolce e riposante, per niente traumatico, di tutto il racconto e come esso richiami alla mente, per il senso di trepidante attesa e di incondizionata fiducia, pagine famose della Bibbia e anche del Nuovo Testamento, ad esempio il sogno di Giuseppe dopo la nascita di Gesù. Già dopo la seconda apparizione, così si esprime Dibitonto (Op. cit., p. 24):
«La sua luce si diffondeva per tutta la stanza ed era come se mi penetrasse profondamente. La radiosa bellezza di quell’essere creava in me un dolce sconvolgimento e il desiderio che non se ne andasse Completamente preso dalla visione, non riuscivo né a muovermi né a pensare ad altro.»
« Cercai di indagare la natura dell’incontro promessomi. Pensai che l’apparizione sarebbe tornata a mostrarsi lassù nella natura anziché tra le pareti di casa. Questa mi parve una risposta; ma sentivo che non era tutto. Ricordai quanto mi aveva detto Raffaele: “Mi rivedrai”. Decisi di restare tranquillo nell’attesa.»
Il racconto prosegue con lo stesso ritmo calmo e fiducioso, con la stessa pacatezza e distensione, ma sempre pervaso da un senso di estatica e progressiva illuminazione.
Una notte, quella del 23 aprile 1980 (non viene detto quanto tempo fosse trascorso dalla prima “visione”), l’Angelo gli comunica che due giorni dopo egli avrebbe dovuto prendre la macchina e recarsi a Finale Ligure, dove avrebbe ricevuto ulteriori istruzioni. Lì giunto, la voce di Raffaele gli dice di proseguire per Calice, indi su per la montagna, fino a un certo punto; poi di proseguire a piedi. È così che Dibitonto riconosce, dopo una tratto di sentiero in salita, il luogo boscoso di cui aveva avuto la visione. Sempre incoraggiato dalla voce angelica, che lo esorta alla serenità e alla fiducia, l’uomo assiste alle evoluzioni di un disco volante dai cui oblò fuoriesce una luce bianchissima.
A questo punto la voce lo informa che il loro è uno dei numerosi incontri decisi dalla fratellanza dell’Amore Universale per portare agli esseri umani aiuto e salvezza. Citando indirettamente un passo del Vangelo di Giovanni, precisa, parlando al plurale, che “loro” vengono da una delle tane dimore del Padre. Poi, dopo averlo assicurato della speciale protezione degli esseri celesti, la voce lo saluta nel nome del Padre universale. Da ultimo, mentre l’Angelo sta con le braccia aperte sotto il disco e altre presenze sono apparse tutto intorno, l’oggetto sospeso si allontana repentinamente, lasciando solo una nube che si dissolve sopra la cima degli alberi.
Questo è stato il primo incontro con una astronave aliena; ne seguiranno altri e Dibitonto verrà anche invitato a salire a bordo e a viaggiare nello spazio. Ogni volta riceve dei messaggi di amore cosmico, peraltro molto generici, i cui contenuti non divergono molto da quelli di alcune celeberrime apparizioni mariane, da Fatima a Lourdes a La Salette. E ogni volta il tutto si svolge in un clima estremamente sereno e gioioso, quasi estatico.
Ben diverso è il tono della stragrande maggioranza dei racconti di “abduction”, ossia di rapimenti di esseri umani da parte di creature aliene, che lasciano un pesante retaggio di paura, angoscia, depressione; così come è diverso, per dire la verità, anche il clima delle apparizioni mariane, che, se da un lato suscitano nei soggetti interessati sentimenti profondi di pace e rapimento mistico, non sono scevri da una vena di inquietudine o perfino di dolore, anche per l’annunzio delle gravi calamità che stanno per abbattersi sul genere umano allontanatosi da Dio.
Sembra che anche le creature “angeliche” apparse a Dibitonto gli abbiano preannunciato gravi catastrofi, ma solo come preambolo alla restaurazione gloriosa del regno di Dio; in ogni caso, nei suoi racconti è del tutto assente quella nota pensosa, malinconica, a volte decisamente mesta o sofferta, che si riscontra nei racconti di Suor Lucia o di Bernadette. Tutto sembra essersi svolto in maniera assolutamente dolce e non traumatica: nessun senso di paura o di angoscia, nessuna sofferenza interiore prodotta dalla straordinarietà dell’esperienza stessa, dalla consapevolezza di non poterla adeguatamente riferire (per non parlare del timore di non essere creduto) o dal contenuto dei messaggi ricevuti.
Che dire di tutto questo?
La storia successiva ci interessa poco; per chi lo desideri, esistono libri, riviste e siti Internet nei quali può apprendere come, poi, Dibitonto abbia cercato di diffondere i messaggi ricevuti dagli extraterrestri, riuscendo anche ad attirare l’interesse, come si è visto, di monsignor Balducci e di altri studiosi. Quello che ci interessa è il grado di attendibilità che possiamo dare non tanto all’esperienza in se stessa, che chiaramente presenta risvolti più mistici e interiori che fisici e tipicamente ufologici, quanto alla plausibilità di una identificazione fra gli extraterrestri e quelli che la tradizione biblica presenta come esseri angelici, intermediari fra Dio e l’uomo.
Non vi è dubbio che, se un Ebreo vissuto qualche secolo prima di Cristo avesse dovuto raccontare una esperienza di tipo extraterrestre, avrebbe adoperato immagini ed espressioni tipiche del suo bagaglio culturale (e che altro avrebbe potuto fare, se no?), più o meno nei termini con i quali troviamo descritto il “carro di fuoco” nella famosa visione di Ezechiele. Questo non significa che tutti i passi della Bibbia in cui si descrive l’apparizione degli Angeli, o anche soltanto alcuni di essi, siano in realtà delle descrizioni di visitatori alieni.
Piuttosto, è evidente che gli alieni descritti da Dibitonto, al netto della possibilità di una truffa pura e semplice o di una forma di esaltazione patologica della facoltà immaginativa, sono e vogliono essere identificato come altrettanti Angeli; del resto, lo dicono esplicitamente: «noi siamo apparsi sovente in passato agli umani, come è narrato nella Bibbia». Di più: essi adoperano un linguaggio molto simile a quello biblico; e le loro fattezze fisiche, se pure possiedono un corpo fisico come lo intendiamo noi, corrispondono alla più classica iconografia cattolica.
La domanda inevitabile che dovremmo farci, arrivati a questo punto, è quale differenza sostanziale possa esservi fra un Angelo e un extraterrestre, pensando a quest’ultimo non come una creatura materiale, ma come una creatura spirituale, fatta di luce ed energia. Se lo è chiesto anche padre Balducci, il quale ha ipotizzati che gli “alieni” visti da Dibitonto possano essere in realtà le anime dei defunti, dal corpo trasfigurato mediante il passaggio liberatorio della morte; ma è stato proprio quest’ultimo a negare decisamente una tale interpretazione.
E allora?
Il minimo che si possa dire, davanti a interrogativi di questo genere, è che gli extraterrestri, se esistono (e tutto lascia pensare che esistano e che da tempo stiano interagendo con gli umani), non possono appartenere ad un’unica specie, ma a molte specie diverse, alcune delle quali, forse, bene intenzionate nei confronti dell’uomo, altre no. Ciò rende ragione delle enormi differenze nei racconti di quanti dicono di averli incontrarti o di essere addirittura saliti a bordo delle loro navi intergalattiche (o interdimensionali, a seconda dei punti di vista), in certi casi volontariamente, in altri come dei puri e semplici rapiti.
Così, se si potessero identificare gli Angeli con gli alieni animati da sentimenti positivi nei nostri confronti, non si vede perché non sarebbe possibile anche l’identificazione opposta, cioè quella dei Diavoli della tradizione cattolica, con gli alieni ostili e malvagi, che non si curano affatto della vita e della serenità degli esseri umani, di cui si servono come cavie da laboratorio e che terrorizzano prima di rilasciarli - posto che alla fine li rilascino sempre.
Ma è possibile, è lecita una tale doppia identificazione, e sia pure solo in via d’ipotesi?
Noi crediamo di sì: ma, appunto, solamente a livello congetturale. Siamo davanti ad una realtà che sfugge alle categorie della nostra mappa concettuale, e per la quale non riusciamo a trovare nemmeno le parole giuste, presupposto indispensabile per riflettere su di un determinato fenomeno e per fare il punto intorno alle questioni che esso eventualmente solleva.
Pertanto, si può dire che stiamo appena incominciando a elaborare le basi minime indispensabili per approfondire la ricerca. Nulla vi sarebbe di più sbagliato, che gettarsi sconsideratamente nei due estremi opposti: della negazione aprioristica e della faciloneria ingenua, credendo di aver risolto una questione che stiamo appena incominciando ad impostare e a valutare, in tutta la sua sconcertante complessità…